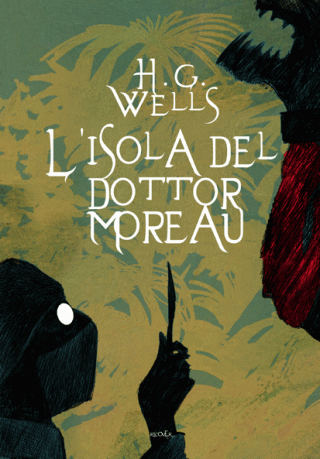 Confesso di aver intrapreso solo di recente la lettura di questo romanzo del 1896, che assieme alla Guerra dei mondi, all’Uomo invisibile e alla Macchina del tempo (tutti scritti nell’arco di tre anni, tra il 1895 e il 1897) costituisce a mio avviso una vera e propria tetralogia che ha definito una volta per tutte di cosa parliamo quando parliamo di fantascienza. Con ciò non voglio dire che comincia tutto lì; mi vado sempre più convincendo che la fantascienza nasce con il terzo e quarto libro dei Viaggi di Gulliver di Swift (1726), passa per il Frankenstein della Shelley, alcuni racconti di Poe, e poi arriviamo a Verne e così via (più altri compagni di viaggio). Però quei quattro romanzi di Wells segnano un momento cruciale. Gli alieni, il viaggio nel tempo, l’invisibilità sono temi che in seguito sono stati presi e ripresi, ma non è solo quello. Wells unisce alla visione di cose a venire una macchina narrativa solidissima che nasconde dietro un’apparente semplicità veri e propri abissi intellettuali. Se non autentici baratri, dove potremmo cadere senza toccare mai il fondo. Questo è tipico di alcuni scrittori inglesi; lo era già di Swift; lo sarà di Ballard.
Confesso di aver intrapreso solo di recente la lettura di questo romanzo del 1896, che assieme alla Guerra dei mondi, all’Uomo invisibile e alla Macchina del tempo (tutti scritti nell’arco di tre anni, tra il 1895 e il 1897) costituisce a mio avviso una vera e propria tetralogia che ha definito una volta per tutte di cosa parliamo quando parliamo di fantascienza. Con ciò non voglio dire che comincia tutto lì; mi vado sempre più convincendo che la fantascienza nasce con il terzo e quarto libro dei Viaggi di Gulliver di Swift (1726), passa per il Frankenstein della Shelley, alcuni racconti di Poe, e poi arriviamo a Verne e così via (più altri compagni di viaggio). Però quei quattro romanzi di Wells segnano un momento cruciale. Gli alieni, il viaggio nel tempo, l’invisibilità sono temi che in seguito sono stati presi e ripresi, ma non è solo quello. Wells unisce alla visione di cose a venire una macchina narrativa solidissima che nasconde dietro un’apparente semplicità veri e propri abissi intellettuali. Se non autentici baratri, dove potremmo cadere senza toccare mai il fondo. Questo è tipico di alcuni scrittori inglesi; lo era già di Swift; lo sarà di Ballard.
Ed è sicuramente il caso dell’Isola. Essa parte da un’ipotesi scientifica che Wells (di formazione biologo; aveva studiato alla Normal School of Science con Thomas Henry Huxley, a sua volta allievo di un certo Charles Darwin), espose in un saggio scritto nel 1895, “I limiti della plasticità individuale”; lo scrittore (ventinovenne, ricordiamolo) ipotizzava che si poteva modificare radicalmente, tramite la chirurgia, la forma di un animale, senza che questo cessasse di vivere. Erano anni in cui la chirurgia e la medicina stavano facendo passi da gigante, specialmente negli ospedali londinesi, tanto da ispirare Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Stevenson (pubblicato solo dieci anni prima del romanzo di Wells). Non meraviglia che ci si interrogasse su dove quel progresso inarrestabile avrebbe potuto portare, ed è quello che Wells fa con L’isola del dottor Moreau. Ancora una volta un medico è protagonista di una sbalorditiva scoperta scientifica, e al tempo stesso di un dilemma morale; ancora non si parlava di bioetica, ma Stevenson e Wells avevano già intuito che la ricerca in campo medico poneva in questione le nostre idee di bene e di male, oltre che di salute e malattia.
Credo che la trama del romanzo sia ben nota, ma meglio andare sul sicuro e richiamarne i punti salienti. Moreau è un biologo che ha dovuto lasciare l’Inghilterra perché travolto da uno scandalo generato dai suoi sconvolgenti esperimenti di vivisezione. Accusato di torturare atrocemente dei poveri animali, lo scienziato si è rifugiato in un’isola poco frequentata del Pacifico, dove ha proseguito i suoi esperimenti, aiutato da Montgomery, un giovane medico che occasionalmente alza un po’ troppo il gomito. Dopo anni di tentativi, è riuscito a trasformare chirurgicamente degli animali, dando loro una forma umana, la capacità di parlare, di camminare eretti, e con interventi di neurochirurgia anche la facoltà di avvicinarsi alle capacità intellettive proprie dell’Homo sapiens. Ha così popolato l’isola con le creature nate nella sua sala operatoria, quella che gli uomini-bestie chiamano “casa del dolore”, perché Moreau lavora senza anestesia (e ciò aggiunge una cospicua dose di horror a questo romanzo).
Il problema è che Moreau vorrebbe creare con la sua ricostruzione chirurgica degli esseri perfetti, superiori all’uomo. Ma ogni volta le sue creazioni lo deludono; conservano sempre degli aspetti caratteristici dell’animale dal quale derivano. E ogni volta che l’uomo-bestia rivela di essere ancora bestiale, troppo bestiale, Moreau regolarmente se ne disinteressa, e passa a lavorare su un altro animale, nella speranza questa volta di giungere allo scopo che si è posto, cioè una creatura che non abbia nulla di animalesco; che non sia guidata dai meccanismi dell’istinto bensì dalla pura ragione.
Vi ricorda qualcosa? Praticamente si tratta dell’esperimento del dottor Viktor Frankenstein ripetuto per decine di volte. Ma Moreau è più prudente; sa di non poter ridare la vita alle parti morte di cadaveri; cerca di modificare il vivente, anche se il prezzo da pagare è una sofferenza indicibile. Però il risultato è sempre lo stesso: la perfezione non viene raggiunta. La creatura artificiale è ancora erede dei mille difetti della carne.
Gli uomini-bestia creati da Moreau si sono organizzati in una sorta di villaggio, dove vivono secondo leggi evidentemente dettate dal loro creatore. Non devono camminare a quattro zampe; non devono nutrirsi di carne; devono essere monogami; non devono uccidere… Vivono, le creature di Moreau, come una tribù primitiva, venerando lo scienziato come una divinità pagana. Lo temono perché ricordano la terribile sofferenza dell’operazione che li ha resi, se non umani, umanoidi; lo temono perché il medico ha la frusta per percuoterli e il revolver per abbatterli. Per gli uomini-bestia, Moreau è una versione primitiva e superstiziosa del Dio dell’Antico Testamento: maschio, violento, autoritario, irascibile e vendicativo.
E qui ovviamente non può non tornare in mente una cosa che Wells disse del suo romanzo: lo chiamò “an exercise in youthful blasphemy” e cioè un esercizio di blasfemia giovanile. Cosa intendesse dire dovrebbe, credo, essere piuttosto chiaro – e così assolutamente fantascientifico, nel senso più genuino del termine, da far girare la testa. Se Moreau è come Dio per gli uomini-bestia, solo perché le loro limitate capacità intellettive non consentono loro, fino a un certo momento almeno, di comprendere che anch’egli è una creatura con dei limiti – chi dice che noi non siamo creature sì, ma non di un essere perfettissimo e onnipotente che chiamiamo Dio, ma di qualche essere in possesso di conoscenze e strumenti assai più avanzati dei nostri, ma anch’essi limitati? Chi ci dice che non siamo il risultato di qualche esperimento avvenuto decine di migliaia di anni fa, nel quale delle scimmie un po’ più brillanti non vennero modificate (geneticamente?) per giungere ad avere facoltà intellettive più ampie dei loro parenti, ma sempre inferiori a quelle dei nostri creatori?
 Voi capite dove questo porta. A ipotizzare una qualche genesi non del tutto terrestre e naturale della specie umana; a immaginare un intervento di alieni tecnologicamente e scientificamente più progrediti che ci hanno differenziato dagli altri primati, ma – e qui sta l’ironia devastante di Wells – non abbastanza da perdere certi meccanismi (aggressività, avidità, crudeltà…) che nelle bestie hanno uno scopo ben preciso (garantire la sopravvivenza) ma che in una specie intelligente possono in ogni momento trasformare la vita in un inferno (cosa che è regolamente accaduta nella nostra storia).
Voi capite dove questo porta. A ipotizzare una qualche genesi non del tutto terrestre e naturale della specie umana; a immaginare un intervento di alieni tecnologicamente e scientificamente più progrediti che ci hanno differenziato dagli altri primati, ma – e qui sta l’ironia devastante di Wells – non abbastanza da perdere certi meccanismi (aggressività, avidità, crudeltà…) che nelle bestie hanno uno scopo ben preciso (garantire la sopravvivenza) ma che in una specie intelligente possono in ogni momento trasformare la vita in un inferno (cosa che è regolamente accaduta nella nostra storia).
E ancora: se Moreau, nonostante quel che credono gli uomini-bestia fino a un certo punto della storia, è tutt’altro che una creatura perfetta (infatti non riesce a creare esseri perfetti nei suoi esperimenti chirurgici), cosa dovremmo pensare noi di quello che abbiamo chiamato Dio? Tutt’altro che perfettissimo e onnipotente, è un demiurgo limitato, un creatore non tanto capace, uno che a noi stupidi uomini e donne sembra chissà cosa, ma in realtà è un pasticcione che ha abborracciato un esperimento tanto tempo fa che ha dato come risultato creature mezze bestiali quali noi siamo, superstiziose, violente, dominate da istinti che non riescono a padroneggiare del tutto. Se non è una visione blasfema questa…
Da un lato siamo ai confini con le dottrine gnostiche, secondo le quali questo mondo in cui viviamo altro non è che la creazione difettosa e ingannevole di impostore, il demiurgo, che si spaccia per Dio ma non lo è (proseguite in questa direzione e finirete dalle parti di Philip K. Dick). Dall’altro Wells applica con infernale coerenza le teorie darwiniane alla specie umana; come noi siamo più evoluti di altre specie, Qualcun altro potrebbe essere più evoluto di noi (vedi i marziani della Guerra dei mondi) – e noi potremmo averne un’immagine altrettanto deformata e vaga quanto gli uomini-bestia di Moreau ne hanno del loro creatore.
Ma il baratro va ancora più in profondità. Ripetutamente Prendick, il malcapitato che finisce accidentalmente sull’isola e scopre man mano, fin verso la metà del romanzo, i suoi segreti, nota che gli animali modificati da Moreau sono di pelle nera, tanto che all’inizio prende il primo che vede per un africano deforme e ritardato. Non sarà mica che il rapporto tra l’inglese Moreau e i suoi sudditi-creature subumani rappresenti anamorficamente il rapporto coloniale? Come c’era un darwinismo scientifico, biologico, c’era anche nell’Inghilterra di Wells un darwinismo sociale, nel quale il diritto degli inglesi di governare indiani, africani, aborigeni australiani, maori ecc. si basava sull’essere quella britannica una società più evoluta, che quindi doveva fungere da guida a quelle più arretrate, poste più in basso sulla scala dell’evoluzione.
Qualcuno dirà che è un bel pretesto per sottomettere e sfruttare qualche popolo dalla pelle più scura che non ha i mezzi per resistere al cannone dell’uomo bianco; però nell’Inghilterra vittoriana ci si credeva. Basti leggere un romanzo come Cuore di tenebra di Conrad (che esce, guarda caso, solo tre anni dopo L’isola del dottor Moreau); nella vicenda di Marlow e Kurz lo scrittore polacco naturalizzato britannico contrappone al colonialismo belga, che mira solo allo sfruttamento dei popoli “inferiori” e al guadagno economico, quello inglese, caratterizzato da una missione civilizzatrice. Ovviamente ci sono dei rischi, come dimostra la storia di Kurz (che per garantirsi l’obbedienza dei congolesi e l’avorio da mandare in Europa si fa passare per un dio, al punto di farsi venerare e anche tributare dei sacrifici); ma quando lo scopo dei colonizzatori è quello di educare i colonizzati, di trasformare i bambini ignoranti e superstiziosi in uomini adulti e ragionevoli, allora la colonizzazione è accettabile.
Oggi questi discorsi sono stati sottoposti a infinite critiche, assolutamente giustificate, che smontano il parallelo sottinteso, nel quale il popolo evoluto, essendo l’adulto, gode di un’autorità morale (e politica) su a quello meno evoluto (o primitivo), che sarebbe il bambino; ma un conto sono i rapporti tra padri e figli, altra cosa quelli tra popoli. Eppure all’epoca di Wells quest’idea circolava; girava anche da noi, dove i personaggi più insospettabili incoraggiavano la giovane Italietta a lanciarsi in avventure coloniali – cosa che regolarmente facemmo, salvo poi combinare disastri… E Wells, non so fino a che punto consapevolmente, la smonta, con i mezzi del romanziere, mostrando che a un certo punto gli uomini-bestie mangiano la foglia, capiscono che Moreau e gli altri due bianchi non sono tanto superiori a loro, che anch’essi provano dolore e possono essere uccisi. Di qui la rivolta, che scoppia quando il puma sul quale sta lavorando Moreau strappa i vincoli che lo tengono bloccato e fugge, e infine uccide il suo creatore, morendo nello scontro, ma chiarendo per tutti che anche gli evoluti umani crepano, come tutte le altre bestie.
Profezia inconsapevole del fallimento del colonialismo? Critica del darwinismo sociale? Messa in discussione della superiorità dell’uomo bianco sulle altre “razze”, prima ancora che la genetica dimostrasse che il concetto di razza (umana) non ha basi scientifiche? Probabilmente nell’Isola del dottor Moreau c’è anche questo. E il bagno di sangue finale, con la morte di Moreau e Montgomery e la regressione degli uomini-bestia, che tornano ai loro originari comportamenti animaleschi, suona la campana a morto per l’impresa di civilizzazione che dovrebbe giustificare il colonialismo: la cultura calata dai colonizzatori sui colonizzati è solo una sottile vernice, sotto la quale restano le strutture “primitive” (noi oggi diremmo “altre”) di comportamento e di comprensione, che alla fine riemergeranno inesorabilmente. E questo non ci dà da pensare rispetto a quel che vediamo accadere in quei paesi mediorientali che sembravano sulla via dell’occidentalizzazione ma che sembrano oggi sul punto di tornare a una cultura islamica ancor più rozza e primitiva? Nel nostro tentativo, forse ipocrita, forse interessato, forse semplicemente maldestro, di “esportare la democrazia” in quei paesi, come ai tempi del colonialismo si voleva esportare la civiltà dell’uomo bianco, non siamo stati anche noi dei dottor Moreau, che in cerca della perfezione abbiamo costruito società assolutamente imperfette e difettose e causato una quantità spaventosa di sofferenza?
E ancor più radicalmente, non c’è in questo romanzo la consapevolezza dei limiti della nostra capacità di capire e conoscere? Lo scienziato Moreau, rappresentante della cultura più avanzata scientificamente nel mondo del 1896, quella britannica (quella che oltre a Darwin aveva annoverato tra i suoi luminari Maxwell e Faraday, tanto per citare qualche nome, quella che aveva scatenato la seconda rivoluzione industriale, che aveva fornito l’umanità di una nuova fonte d’energia – il carbone – che oggi pare arcaica, ma allora era rivoluzionaria), sembra un dio solo ai limitati uomini-bestia – ma noi lettori comprendiamo che la sua apparente onnipotenza ha dei limiti intrinseci, forse, per citare uno scrittore vivente, un vizio inerente, che porta sempre a creazioni difettose. Inorgoglitosi per le sue conquiste, l’uomo bianco si crede al culmine della creazione; ma né lui né la sua civiltà sono perfette, né lui né le sue creazioni sono libere dalle tare originarie.
Solo diciott’anni dopo la pubblicazione del romanzo di Wells la morte di un aristocratico austriaco scaglierà l’evoluta e superiore Europa in uno spaventoso bagno di sangue dove il primitivo e l’animalesco torneranno a emergere nelle trincee dei vari fronti della Grande guerra. Collocato storicamente, L’isola del dottor Moreau fa riflettere, e non cessa di aprirci baratri sotto i piedi.
Esattamente quel che ci si deve aspettare da un classico della fantascienza; che deve unire il sense of wonder a un sano sense of doubt. Cosa che a Herbert George Wells riusciva maledettamente bene.
